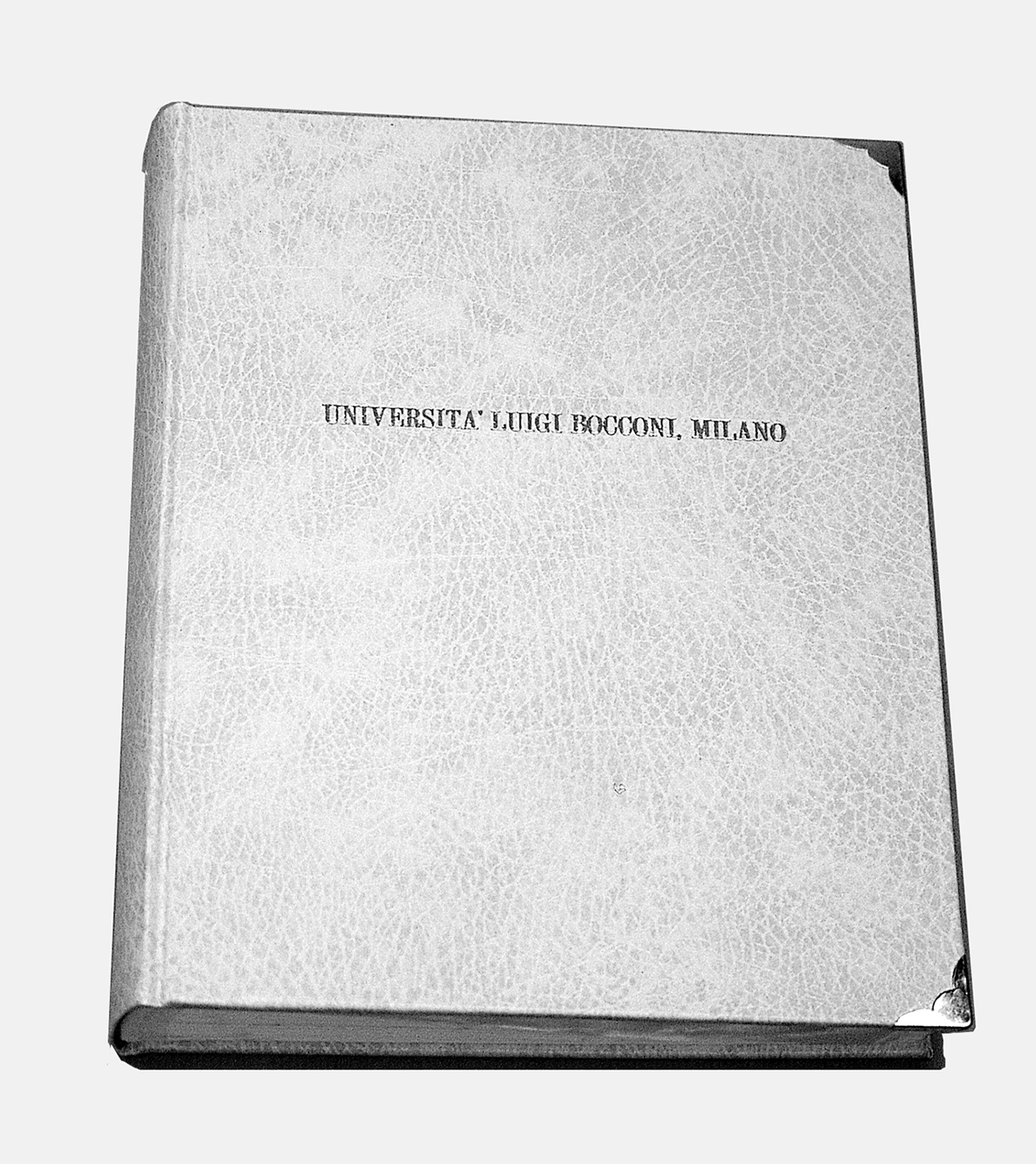Lanfranco Caminiti, Produzione d’arte a mezzo di merci
Produzione d’arte a mezzo di merci
In occasione della mostra di Mauro Folci, Laboratorio d’Arte, Università di Roma La Sapienza, Marzo 96
Devo confessare il mio imbarazzo a partecipare a questa introduzione al lavoro di Mauro, imbarazzo che nasce da un episodio che vorrei raccontarvi, perché mi sembra un buon modo per esorcizzarlo, e perché mi ha dato qualche spunto di riflessione di cui vorrei mettervi a parte.
Sui muri di Roma, dunque, quindici giorni fa circa, appare un manifesto, a lungo reiterato, che sotto l’egida di Alleanza Nazionale, recita cosi: SALVARE L’ARTE. Esso contemplava a mò di firma una lunga sequela di nomi di nani e ballerine di seconda fila, che, presumo, dovrebbero farsi carico del gravoso compito di salvare 1’arte.
Per riflesso condizionato, per istinto, mi sono detto: cazzo, è giunto proprio il momento di SPARARE SULL’ARTE (lo dico in senso metaforico, tanto quanto ritengo fosse metaforico l’invito a salvarla, invece, l’arte). Una reazione spiccia, quasi a scacciar via un elemento di confusione delle cose: ma come, non erano loro quelli che proscrivevano gli autori, che bruciavano i libri in piazza, che toglievano dai musei “l’arte degenerata” (che era poi tutta l’arte del Novecento), salvando, ahinoi, gli acquarelli di Hitler?
Poi aggiungevo: eppure in Italia intercettarono fior d’avanguardia artistica (da Marinetti a D’Annunzio), la protessero con Bottai, coccolarono o fecero baruffe con fior d’intellettuali, dal primo Prampolini a Papini e Maccari ormai maturi, da Alvaro a Guttuso (giovani), sostennero innovazioni nel cinema (da Blasetti a Rossellini) e in architettura (valga per tutti, Persico). Non si tratta solo della perenne disposizione degli intellettuali italiani ad assecondare i regimi, al conformismo. Certo, c’è anche questo; ma spesso è per la pagnotta, e questo fa abbastanza tenerezza e malinconia. A scorrere i lunghi elenchi depurati (e quanto depurati) degli intellettuali italiani a busta-paga sui libri contabili del Minculpop, si è più stupiti dalla esilità degli emolumenti che dal numero delle persone coinvolte. Molti passeranno presto su altri libri contabili. Però non è questo il punto: il fascismo intercettò e mise al lavoro tanti intellettuali, anche facitori di cose dignitose e belle. Esso, in quanto regime, organizzò l’arte al servizio dello Stato. Era, d’altra parte, quanto andava accadendo nel campo del Socialismo Reale. Ovvero, L’ARTE ERA POLITICAMENTE MESSA AL LAVORO: essa si faceva ancella (lo ripeto, dove assecondava il potere politico) d’un altro discorso simbolico sul mondo, sovrapponendo questo linguaggio, questo codice formativo e di forma, al proprio. E’ qui lo scarto, il passaggio rispetto al rapporto che sempre l’arte ha avuto con il “potere mondano”; beninteso, le committenze di signori e proprietari, di papi e belle donne, di mercanti e mercenari, che volevano magnificare il proprio casato o mostrarne 1’acquisita dignità, erano sempre gesto “politico”. E non è che il sarcofago di Ilaria del Carretto o il Palazzo del Tè siano meno splendidi per questo. Ma è quando la politica diventa ordinatrice del mondo (e dei suoi linguaggi), e quindi rileva l’arte come potente mezzo di edificazione di questo mondo, è allora, è in questo secolo, che si è verificato lo scarto, che l’arte è entrata al servizio della politica, ovvero ha perso i suoi connotati di APORIA.
Sottolineo questo concetto di aporia, perchè non ho mai creduto ad un’ipotesi assoluta dell’arte, un’ipotesi che rende l’arte ingenua, quella che la vede come eversiva per i suoi contenuti e le sue forme rispetto il Potere costituito, come fosse essa stessa fonte d’un potere costituente. L’aporia, la contaminazione tra la storicità dell’arte e il trasfigurarsi della bellezza in un farsi umano, mi sembra sia poi il codice genetico stesso dell’opera d’arte, ciò che distingue una sua qualità dall’immondizia, distingue ciò che ci commuove o ci ferisce dalla banalità.
Ma la questione si sposta ancora: liberatici dai fardelli e dalle visioni orribili della politica ordinatrice del mondo, abbiamo abbracciato il mercato come luogo dell’eguaglianza e della libertà, e la democrazia intesa come surrogato di questa eguaglianza e di questa libertà. L’Economia, la Produzione sono diventate le buone fate del nostro destino, “dalla culla alla tomba”. La produzione di massa ha ordinato il mondo secondo le sue leggi di mercato, quelle che assolutizzano l’individuo (o la famiglia o la comunità) come soggetto economico. Persino la Politica le è sottomessa: non ci sono Stati e nazioni, bandiere e frontiere che possano arrestare la forza d’urto, di riordinamento che ha l’economia. E la Scienza, l’invenzione, la creatività ne sono diventate addirittura supporto.il pensiero astratto e il pensiero simbolico, quindi il linguaggio formale, il linguaggio della forma, sono diventati il presupposto della produzione di merci attraverso la Macchina, attraverso il computer, attraverso l’Intelligenza Artificiale. La produzione di massa usa il linguaggio formale come suo codice formativo delle merci, usa dunque il linguaggio dell’arte. Le merci invadono la nostra vita titillandoci al loro acquisto e al loro consumo non solo attraverso il concetto dell’utile, ma anche attraverso il concetto del bello. Il superfluo, il lussuoso, quanto esula dalla necessità e dall’utilità (e quindi ciò che era presupposto libero, il bello, il gusto) sono invece direttamente messi al lavoro, massificati. Essi non sono più appannaggio di fasce privilegiate (o almeno questo recita il messaggio promozionle) ma occasione alla portata di tutti, sono miniaturizzati in ogni oggetto d’uso che entra nelle nostre case. La banalizzazione della produzione di massa rende banale il bello. Essa rovescia orribilmente l’intuizione della pop-art che banalizzava la produzione svelandone il suo lato artistico, estraendolo dal contesto del consumo, giocando sul tema della sua riproducibilità. Non più “ogni opera d’arte è un’opera di produzione”, “ma ogni opera di produzione ha in se un connotato d’arte”. L’arte non riesce più a distanziarsi dalla sua storicità (adesso: il mercato, l’economia), anzi vi si immedesima. Non riesce più a produrre aporia.
Siamo più in là del rapporto politica/arte, che era anche un poter fare (un giocare sul margine dell’aporia), oltre che un dover fare. Qui non c’è più il proprio poter fare, perché è la produzione l’assoluto poter fare, il fare le cose. La potenza guadagnata dall’arte (dalla scienza, dal linguaggio simbolico), e per questa via, la potenza con cui intendono il proprio fare gli intellettuali, è potenza dell’economia. La potenza del mezzo viene travisata per potenza della capacità creativa (e cito a mò di esempio, la televisione). L’intelligenza della macchina, la forza del linguaggio simbolico della produzione, è intelligenza morta, come il lavoro che si accumulava nella macchina capitalistica era lavoro morto.
“Salvare l’arte” allora? Credo di poter dire adesso che quest’espressione mi colpisce più per la sua profonda astoricità, per il suo provincialismo, per il suo velleitarismo: come a proporre un impossibile ritorno alla “creazione artistica”, alla “genialità dell’artista”, al “valore incommensurabile per un popolo e per la sua nazione del lavoro degli intellettuali”, quando esso è infinitamente al di sotto della qualità artistica che può mettere in campo la produzione di massa, perché essa è infinitamente più capace di memoria, perché essa è infinitamente più capace di immaginazione, perché essa è infinitamente più capace di linguaggio, di forma. Illudersi ancora nel gesto d’arte individuale come gesto d’opposizione è di una ingenuità sconfortante. Per usare un’ espressione un pò retro, che confina con il pessimo gusto, dato che oggi dichiararsi rivoluzionario è considerato terribilmente retrò e di pessimo gusto, dico che ogni gesto d’arte è un gesto contro-rivoluzionario, un gesto che perpetua la catena di comando dell’economia, della produzione.
Ma è attorno questo crinale che dobbiamo porre la domanda sulla possibilità stessa, sul significato stesso di fare arte, di essere artisti oggi: la produzione generale è simbolica del bello e non solo dell’utile. Essa cristallizza in forme di dominio un’aspirazione generale al bello, una disposizione collettiva alla forma che è ormai dato incontrovertibile. Su questo lato possiamo misurare le nostra domande. Cosi come poniamo le nostre domande sulla possibilità di un produrre libero degli uomini, di una liberazione dalla condanna al lavoro, a partire dal dato incontrovertibile della crescita enorme dell’intelligenza generale, della conoscenza generale, della capacità generale di fare. Anche qui, la cooperazione del fare umano è piegat a produrre forme di dominio: invece di un tasso maggiore di liberazione dal lavoro, ci ritroviamo con forme di nuove servitù del lavoro.
Da questa crescita del senso comune, quindi di una disposizione generale al giudizio e al gusto (che era l’acquisizione kantiana e che per la Arendt è il fondamento stesso d’ogni idea democratica della politica) possiamo ripartire.
Non è una disposizione pessimistica la mia: semmai considero pessimistico quella sorta di cretinismo tecnologico che oggi è di moda e che considera il dado irreversibile dell’acquisizione di conoscenza e di capacità insita nelle macchine come dispensatore di una maggiore libertà. Quando è proprio qui il grumo delle contraddizioni.
La rivoluzione tecnologica che viviamo non è come le altre, non è come l’aratro o il basto per le bestie o il vapore e le caldaie; non c’è solo un connotato di riduzione della fatica, ma il coinvolgimento della capacità creativa di ognuno. La potenza della macchina, le potenza di un ciclo produttivo è tanto maggiore quanto maggiore è la sua capacità di codificazione, di linguaggio, di invenzione. Sono coloro che il ministro americano del lavoro chiama “analisti simbolici” i produttori della maggiore quantità di ricchezza. Ed è economicamente accertato che la primazia industriale di una nazione si gioca oggi sulla sua “capacità cognitiva” e non certo sulla riserva aurea. Eppure, tanto più il lavoro potrebbe scrollarsi di dosso la dimensione della fatica per la riproduzione, potrebbe avvicinarsi al mondo libero della creatività, a maggior ragione della crescita della capacità generale di intelligenza, tanto più assistiamo a nuovi fenomeni di mortificazione generale. Io ritengo che viviamo tutti al di sotto della nostre capacità e possibilità, perché la forza della produzione generale è mortificata e avvilita nella produzione di merci insulse. Non è vero che viviamo sopra-registro, che subiamo crisi da sovraproduzione: è vero proprio l’opposto, che una enorme capacità produttiva è tenuta alla catena, che una enorme capacità creativa, artistica, come capacità generale, è tenuta alla catena.
La comunità linguistica degli intellettuali, degli artisti, degli analisti simbolici, che mai come adesso ha rappresentato una volontà di potenza, quella comunità che non ha nazione o lingua, che viaggia tra Ginevra e Washington, tra Bruxelles e i centri universitari, tra vernissage e prime d’Opera, portandosi dietro una visione turistica del mondo, non si è rivelata poi l’ambito vero di quella comunicazione libera di cui parlava Habermas, almeno finora.
Non so se questo potrà accadere se prima non riusciamo a leggervi dentro, a considerarla non come una “comunità elettiva”
ma come uno strato di classe al cui interno ci sono forti mobilità, non solo transoceaniche, ma discendenti e ascendenti (basterebbe pensare al recente episodio del licenziamento dei 40.000 alla ATT, dove appunto quelli mandati via erano in buona parte quadri di medio e alto livello). Se prima non riusciamo a considerarla come strato produttivo (forse il più importante, dato che i suoi codici hanno investito tutti i caratteri della produzione, informando quindi anche l’attività analfabeta).
Ecco, spero proprio di esser riuscito a mettere in crisi ogni idea ingenua dall’arte, ogni idea d’una sua eversività, per così dire, “naturale”. Qui la Natura che abbiamo di fronte è la Produzione. Ma che l’arte, appunto, sia tutt’intera produzione mostra anche le enormi possibilità che ci stanno di fronte, intrecciate adesso con i rischi d’essere soltanto dei “riproduttori”. Non ci sono soluzioni a breve, se non nella tensione a costruire un cammino di sottrazione, di liberazione, di ribellione, di creazione.
Contratto a termine standardizzato. Chi acquista/vende un future assume l’obbligo di acquistare/vendere a una certa data e a un certo prezzo l’ammontare di beni sottostante al contratto. I future possono riguardare merci, tassi d’interesse, obbligazioni, indici azionari, valute. Nel caso delle merci alla scadenza del contratto è prevista la consegna fisica dei beni. Nel caso di strumenti finanziari, come gli indici di Borsa, può essere prevista la liquidazione in denaro del differenziale tra il prezzo di mercato e quello stabilito dal contratto. I contratti future sono trattati su mercati regolamentati dove un organismo, detto Clearing house, ne assicura l’esecuzione.
Ritratti fotografici di sette facoltà universitarie di economia tra le più autorevoli dei paesi industrializzati (G7):
London School of Economics, Londra
Yale University, New Haven
Universitat zu Koln, Colonia
HEC Hautes Etudes Commerciales, Parigi
Università Luigi Bocconi, Milano
McGill University, Montreal
Hitotsubashi University, Tokio
MLAC Università La Sapienza, Roma 1996